Come è andata la vostra estate? Spero bene, come si suol dire. Avevo scritto un racconto lungo 50mila battute sulla mia ma siccome mi sono rilassato parecchio e non ho più voglia di scontri digitali né di perdere lavori né di incappare in altre amabili occorrenze tipiche del nostro tempo, ho tolto dal testo ogni possibile contenuto offensivo. Il risultato finale può apparire un po’ monco ma credo che comunque mantenga inalterata tutta la sua potenza espressiva. Ho accarezzato per un po’ l’idea di farne un piccolo volume, ma alla fine ho deciso di pubblicarlo qui in forma integrale, per voi amici della newsletter, eccolo:
“BELLO IL MARE.”
Ho scritto anche alcune storie per i giornali, nel caso vi foste persi qualcosa le trovate qua sotto. Queste sono un po’ più lunghe perchè mi pagano a battuta.
Storia di una seduzione editoriale (Domani - 31.08)
L’aura di Adelphi e la mia esperienza come autore.
Sin da bambino ho sempre letto di tutto: libri, giornali, riviste, fumetti, cataloghi e qualsiasi altra cosa trovassi di stampato da mettere sotto gli occhi e per qualsiasi cosa intendo proprio qualsiasi cosa, comprese pubblicazioni impossibili per un ragazzino nato a Bolzano come Il Gommone e la nautica per tutti.
Forse per via di questa fame insaziabile – oltre che per la distanza della città dove sono cresciuto dal mondo della grande editoria – per i primi decenni della mia vita non mi era mai passata per la testa l’idea di leggere o non leggere un libro e di comprarlo o non comprarlo sulla base di chi ne fosse l’editore. In quegli anni Einaudi o Scannacchiappolo editore per me pari erano, mi interessava in primis l’autore (quando ne scoprivo uno che mi piaceva leggevo tutte le sue opere, una dopo l’altra), poi il tema, la copertina e infine il titolo. Nient’altro. Ancora oggi vedo nella libreria di mio padre diversi libri di editori improbabili, segno che da qualcuno devo aver preso.
La mia prima raccolta di articoli fu cercata e poi pubblicata da una piccola ma allora promettente casa editrice, diventai amico dell’editor e parlai spesso con lui delle dinamiche dell’industria; avevo appena finito di scrivere il mio primo romanzo e continuare a non avere un’idea di come funzionasse l’editoria non era per uno scrittore quell’idea saggia che può essere per un lettore.
Come molti editor non solo italiani anche quell’editor aveva un solo mito: Adelphi, la casa editrice di Roberto Calasso. Io avevo qualche libro Adelphi a casa, ad esempio avevo molto amato Che paese, l’America di Frank McCourt e La versione di Barney di Mordecai Richler, all’università avevo studiato Nietzsche nell’edizione Colli e Montinari – nettamente superiore a qualsiasi altra edizione italiana. Ricordavo ancora molto bene anche il cardo sulla copertina della Critica della ragion pura di Kant, un libro che in un inconscio gesto di sopravvivenza un mio compagno di corso lanciò giù da un camminamento sospeso sopra la biblioteca del dipartimento di filosofia, per fortuna senza prendere nessuno in testa. Comunque una bella edizione, si capiva anche dal rumore compatto che fece atterrando sul tavolo e terrorizzando le persone assorte nello studio. Le colpe lì erano di Kant, il cui libro, come disse con precisa insuperata un suo contemporaneo, «sembra scritto su carta da parati».
Allora però sapevo riconoscere anche i Supercoralli, il blu di Sellerio, il giallo di Stile Libero, la carta grezza di Strade Blu, solo per citare alcune delle collane che abbondavano sugli scaffali delle librerie di quell’epoca; di nessuna di quelle collane però avrei comprato un libro a scatola chiusa, così come non lo avrei comprato di Adelphi.
Poi un giorno, durante un viaggio in tram a Milano diretti chissà dove, il mio primo editor disse con il fare corrucciato di chi sta parlando di un trucco fondamentale, un trucco di cui si capisce l’assoluta importanza ma che non si riesce a replicare: «Lo sai quante copie ha venduto Leggere Lolita a Teheran? Ed è un libro totalmente illeggibile», forse non disse “totalmente illeggibile” bensì qualcosa di peggio, era ed è rimasto sempre piuttosto tranchant. Il senso comunque era che Adelphi oltre a pubblicare bei libri era anche capace come nessun altro di vendere libri brutti donandogli un alone di importanza, il che è una specie di super potere e, ammettiamolo, il sogno indicibile di ogni piccolo e grande editore.
Per inciso non ho mai letto Leggere Lolita a Teheran – per qualche motivo quella recensione non mi aveva attirato granché – e non mi stupirei se si trattasse in realtà di un libro bellissimo, il punto però qui è un altro, ed è quello su cui i detrattori e i devoti di Adelphi si trovano tutto sommato d’accordo: i libri della casa editrice hanno un’aura, un qualcosa che li qualifica anche al di là del testo. In quell’occasione comunque io pensai più che altro alle copie che si sarebbero potute vendere anche nel caso il mio romanzo si fosse rivelato brutto e, credo sfregandomi le mani, telefonai al mio agente per chiedergli di aggiungere Adelphi alla lista degli invii del mio manoscritto. Acconsentì, facendomi però velatamente capire che sarebbe stata una perdita di tempo perché quella casa editrice molto di rado pubblicava autori italiani viventi.
Andò a finire che fra tutti gli editori a cui era stato inviato il manoscritto Adelphi fu la prima casa editrice a richiamare e lo fece nella persona di Matteo Codignola. In Memè Scianca Calasso ricorda il ruolo di grande scopritore di talenti di Ernesto Codignola, Matteo, suo pronipote, si comportò con me in modo simile, per cui ho riconoscenza nei suoi confronti nonostante il suo carattere non sempre facile (scommetto che lui direbbe lo stesso di me ed entrambi riterremmo queste rispettive valutazioni ingiustificate, il che nonostante tutto mi fa sorridere).
Ci incontrammo, ci trovammo d’accordo su molte cose che non ci piacevano (ottimo segno), poi mi regalò un sacco di libri Adelphi e tanti altri me ne fece recapitare a casa per un lungo periodo. Capii troppo tardi che il meccanismo era simile a quello dello spacciatore che inizia qualcuno a una droga per indurgli una profittevole dipendenza.
Ogni libro pubblicato da Adelphi in ogni singola collana doveva passare per il vaglio diretto e attentissimo di Calasso, il che credo non accada in nessuna casa editrice di quelle dimensioni. Sta di fatto che considerati i suoi altri compiti e l’attività di scrittore, questo creava una mole di lavoro enorme e i tempi di conseguenza erano molto dilatati, nel frattempo arrivarono delle offerte da altre case editrici importanti e il mio manoscritto prese un’altra strada. Tuttavia più si accumulavano in casa mia i titoli Adelphi provenienti, via Codignola, dai meandri più profondi del catalogo, più andava finendo la mia indifferenza storica e – a quel punto me ne rendevo conto – quasi blasfema nei confronti di quale fosse la casa editrice di un determinato libro.
Mi era diventato chiaro il grande lavoro che c’era in tutta la grande editoria – non solo in Adelphi – e mi sembrava anche di aver capito cosa s’intendeva con la tanto discussa aura della casa editrice di Calasso, quell’aura che la rendeva amata, odiata e soprattutto invidiata.
Quello che però ai detrattori mi pare sfugga è che fra i tanti fattori che contribuiscono alla creazione di quell’aura il più importante sia la pratica di pubblicare meno libri brutti possibile. So che sembra una contraddizione ma la capacità di vendere in qualche occasione molte copie di (presunti) brutti titoli dipende direttamente dal fatto di averne fatti in precedenza il meno possibile. È un segreto di Pulcinella ma nell’editoria italiana – che con il suo sistema di ordini e di resi assomiglia molto a uno schema Ponzi – gli editori devono continuare a inondare le librerie di nuovi titoli, pena il collasso finanziario, e quindi l’idea apparentemente semplice di pubblicare meno libri brutti possibile diventa all’atto pratico qualcosa di difficilissimo.
Si può perciò rovesciare la questione: molti editori hanno tanti bei titoli in catalogo, pochissimi editori hanno pochi titoli brutti, da questo deriva il fatto che sempre pochissimi editori siano in grado di offrire al lettore una sorta di garanzia a scatola chiusa, e questo nonostante un rapporto fiduciario del genere sia la strategia commerciale più efficace in assoluto.
Un’altra questione fondamentale è quella di intendersi su cosa sia non tanto un libro bello quanto un libro brutto: i libri non belli di Adelphi sono spesso strani, anomali, periferici, complicatissimi, talvolta furbeschi o del tutto esoterici, ma proprio brutti solo di rado. Dei circa 500 Adelphi che ho a casa oggi ce ne sono solo una manciata che potrei definire autenticamente brutti mentre esistono case editrici di cui un libro su due è un delitto contro le foreste. Fra quei pochi libri brutti non potrei poi mai trovare un instant book, il libro di un influencer, il romanzo di un non scrittore, il titolo scritto con la zappa da un giornalista televisivo.
Il brutto Adelphi, quando capita, è un brutto che prende comunque sul serio il concetto di libro e ha alle sue spalle un’idea dignitosa di letteratura: se la ciambella non riesce con il buco siamo piuttosto certi che almeno sia stata pensata in origine come una ciambella. Non è poco e credo conti molto di più di tutte quelle cose, pur importanti, che vengono sempre citate parlando di Adelphi: le copertine, una certa sprezzatura, il misticismo felicemente privo di kitsch, l’estrema selettività nei confronti degli autori italiani (se vuoi farti amare da un borghese, si sa, devi trattarlo un po’ male), il porsi come alternativa alla chiesa dei comunisti e a quella dei cattolici (fino a farsi un po’ chiesa a propria volta, seppur di netta minoranza), l’apertura a un ampio numero di autori mitteleuropei che prima in Italia erano ignorati o poco valorizzati. E anche un certo snobismo, è vero, ma non nel senso che Giuseppe Pontiggia, autore e consulente di Adelphi, dava alla parola ovvero «innamorati (delusi) della massa», quanto piuttosto in quello di giudizio estetico intransigente, sensibile per opposizione alla vulgata del tempo storico, ma senza alcun rammarico nei confronti di questa mancata riconciliazione.
È significativo che proprio in Bobi, Calasso si rifiuti di usare per Bazlen la parola “sciamano” perché ormai deviata dall’epoca verso un significato intollerabile e non più rappresentativo di quello che è stato il primo ispiratore del catalogo Adelphi.
Al centro del progetto adelphiano mi sembra ci sia l’estetica e nello specifico un’estetica che si declina su tanti valori diversi ma di certo rifiuta l’idea di poter essere raccolta in blocco all’interno di una dimensione meramente razionale e analitica, una condensazione che renderebbe il progetto della casa editrice la versione solo poco più complessa di un moderno power-point, di una tag line o di un’altra di quelle semplificazioni idiote che scandiscono la quotidianità lavorativa del nostro tempo storico.
L’aura di Adelphi, per come ho imparato a percepirla, risiede precisamente in quella cifra estetica che attraversa i testi e le copertine e proviene dalla costanza sempre in divenire di un progetto che rifugge il conformismo almeno quanto rifugge le incrostazioni dell’anticonformismo. Un progetto che assomiglia a una specie di lepre in una perenne fuga in avanti che però non si castra nell’avanguardia ma ricerca sé stessa e il simile a sé in ogni tempo storico e in ogni spazio geografico. Più che un canone è un’intuizione di somiglianza che si coglie per un momento e altrettanto in fretta scompare.
Tutto questo è naturalmente arbitrario, spesso ingiusto, e lascia fuori dal proprio perimetro moltissimi grandi libri ma quella che per tanti aspetti è la miglior casa editrice italiana non è mai stata per questo una casa editrice totale, né tanto meno unica nel senso di assoluta monopolista della qualità, quanto piuttosto quella con l’identità più chiara grazie a una intransigenza inscalfibile, silenziosa e fedele a sé stessa. È anche un caso felicissimo figlio non solo di intelligenze straordinarie ma anche di circostanze sociali, storiche ed economiche propizie; penso per contrasto alle persone di grande talento e capacità che oggi non avendo né i mezzi né il patrimonio sociale per lanciarsi in imprese autonome lavorano nei grandi gruppi, sempre forzatamente alle prese con logiche che non sono quelle del laboratorio editoriale ma quelle della grande industria. Per non parlare del problema di vivere in un tempo storico in cui i device digitali mangiano tutto il tempo di attenzione dei possibili lettori.
Perché possa esistere qualcosa di raro e prezioso come Adelphi sono insomma tantissime le stelle che devono allinearsi, non solo il talento generazionale e indiscutibile di un maestro assoluto come Calasso. Ciò non toglie che molti editori italiani mettano la loro intransigenza in battaglie politiche, morali e di attualità e siano poi disposti con una certa docilità a scendere al compromesso commerciale e che questo invece non sia mai stato il caso dell’Adelphi di Roberto Calasso. Questa convinzione, nascosta e ostinata, finisce nel lungo periodo per fare sentire in maniera chiara e forte la voce di un marchio editoriale.
Un’altra delle caratteristiche di Adelphi che più sarebbero da imitare e raramente vengono imitate è la prospettiva temporale lunga: l’idea cioè di fare sacrifici oggi per raccogliere frutti domani. È anche grazie a questa prospettiva di ampio respiro, credo, che Adelphi ha potuto pubblicare con successo libri belli che sarebbero stati del tutto impossibili per gli altri editori.
Chi altro sarebbe mai riuscito a far leggere all’intellighenzia italiana, afflitta dai suoi ben noti limiti di conformismo, libri come il crollo della mente bicamerale di Julian Jaynes o i saggi di James Hillman? La stessa cosa è successa spesso con la rivalutazione di autori già pubblicati da altri, pur capaci e agguerriti, editori: scrittori come Emmanuel Carrère o Roberto Bolaño, per arrivare fino all’esempio più noto: Georges Simenon. Lo scrittore francese accenna in Memorie intime al fatto che in Italia i suoi “romanzi duri” non fossero presi sul serio come in altri paesi – il conformismo italico, sempre lui – e questo nonostante gli sforzi di Mondadori, allora suo editore, di organizzare delle conferenze accademiche proprio allo scopo di elevare il suo status. La realtà è che non servivano conferenze, serviva un’aura, che è esattamente ciò che Calasso è riuscito poi a fornire a Simenon.
Forse perché coglieva l’insufficienza di una lettura razionalista della realtà, sta di fatto che Calasso è stato anche un grande interprete dei desideri profondi del suo pubblico, che, pur “alto” e spesso colto, non era per nulla ignifugo alle mode, alle fascinazioni istintive, alla tendenza a mitizzare. Un pubblico sensibile più al fascino silenzioso dell’esclusione che ai tentativi espliciti di seduzione.
Nelle tante straordinarie quarte di copertina scritte da Calasso emergono almeno due capacità: 1. Quella di invogliare, con una descrizione di poche righe, alla lettura di un libro cogliendone in maniera chirurgica i punti di interesse, senza per questo stravolgere la natura del testo piegandolo alle mode del momento. 2. Una grande conoscenza dei vizi e delle virtù del pubblico a cui il libro era destinato: uno straordinario senso del lettore ideale, che non era tanto un target di mercato quanto piuttosto qualcosa verso cui allo stesso lettore piaceva tendere.
In questo senso un libro Adelphi era sempre anche un libro “migliorativo” ma non in termini sociali o morali, bensì individuali e spesso laterali. Niente come una quarta Adelphi ben riuscita sa cogliere il potenziale lettore con le difese abbassate e colpirlo esattamente là dove si annida la sua propensione all’acquisto. Lo fa il più delle volte senza l’ausilio di fascette e blurp – tutte cose che comunque all’occorrenza anche Adelphi usa – ma soprattutto senza utilizzare iperboli ingiustificate e paragoni grotteschi da venditore pronto a celebrare l’improbabile capolavoro oggi, rovinandosi così la credibilità di domani. (Continua su Domani)
Il Salento è un’isola (Reportage - Il Foglio 30.08)
Viaggio nella provincia più famosa della galassia
“Se infili una mano nel terreno il calore di solito si avverte solo nei primi uno o due centimetri, in questi giorni si riesce a sentire fino alla punta della dita.” racconta Giovanni Melcarne, imprenditore olivicolo e una delle mie fonti di lunga data sul disastro della Xylella. Melcarne compie esperimenti con innesti e semenzali sperando di trovarne di resistenti al batterio ed è una delle poche voci che nel Salento si sono sempre spese per una stretta collaborazione fra agricoltori, scienziati e ricercatori. Siamo in ufficio, nel suo frantoio a una manciata di chilometri da Santa Maria di Leuca, benedetti dal ronzio dall’aria condizionata. Una cappa di calore si è abbattuta sul Salento da metà giugno e si è mantenuta costante per oltre un mese e mezzo lasciando raramente la possibilità alla tramontana di agitare il mare e rinfrescare le persone. Ci si muove così fra i pochi ambienti condizionati come fra oasi nel deserto, le liste d’attesa per farsi installare nuovi impianti sono lunghissime, i rivenditori sfoggiano larghi sorrisi, tutti gli altri boccheggiano anche di notte, quando la temperatura scende di forse due o tre gradi, attorno ai 36 sulla costa, qualcosa di più nell’entroterra: è l’estate del faugnu, un termine che in salentino indica sia il caldo asfissiate che il vento da sud che lo porta con sé. Secondo Melcarne potrebbe essere interessante cercare di capire se la mancanza di una copertura vegetale – dopo che la Xylella ha ucciso 85mila ettari di ulivi rendendo il Salento in larga parte un territorio secco e brullo – c’entri qualcosa con questa ondata di calore anomala, per il momento però è solo un’ipotesi da verificare. Qui ci sono arrivato dentro un’altra bolla di aria condizionata, quella della mia auto; da giorni sto attraversando bretelle, statali e superstrade deserte sotto il sole della controra, un’attimo prima dell’inesorabile invasione agostana che si profila all’orizzonte.
Mi muovo nel tentativo di tracciare una breve mappa aggiornata del Salento a vent’anni circa dall’inizio del travolgente boom del turismo. Nel 2015 uscì “Lascia stare la gallina” (LSG) – un romanzo appena ripubblicato negli Oscar Mondadori – un libro in cui raccontavo le vicende di un coro di personaggi durante la lunga e trafelata estate salentina del 2011: giovani che affollavano le dance hall in spiaggia, le discoteche, i festival, la Notte della Taranta, lavoratori del turismo, ex contrabbandieri in cerca di riposizionamento, ristoratori, camerieri, spacciatori, dj e sullo sfondo il mondo del potere locale che si preparava al tramonto del berlusconismo. In quel momento il turismo nel Salento aveva già raggiunto da circa dieci anni una scala prima del tutto impensabile ma erano ancora da venire lo strapotere dei social, gli influencer, il successo dei populisti digitali di ogni risma, così come la TAP - il gasdotto transadriatico che approda nell’est del Salento – non era ancora diventata una battaglia politica, il disastro della Xylella doveva ancora deflagrare e il Covid era uno scenario fantascientifico Sono passati soltanto dieci anni ma durante questo periodo si è definitivamente consumato anche il passaggio dalla società della televisione (simbolo locale: la statua di Manuela Arcuri sul lungomare di Porto Cesareo) a quella di internet (simbolo locale: Chiara Ferragni in visita alla basilica di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina).
Molti dei personaggi di LSG allora correvano in macchina per le statali e le vicinali che collegano quella costellazione umana che sono i 97paesi del Salento e ai loro lati scorrevano inevitabilmente filari e filari di ulivi verdi, sempre e solo ulivi perché il Salento era sostanzialmente una monocultura. Oggi chi arriva dalla Bari-Lecce incontra una cupa distesa di ulivi morti che prima quasi spaventa, poi stringe il cuore. All’altezza della centrale di Cerano le macchie grigie nelle chiome crescono di grandezza e di frequenza fino a quando la superstrada non si ritrova a scorrere fra due spettrali file di alberi morti, un cimitero lungo decine e decine di chilometri. Ogni tanto appare la chiazza verde di un uliveto di Leccino – una delle due cultivar resistenti al batterio – come fosse una distorsione subliminale nel segnale e poi di nuovo tronchi e rami secchi, scheletri senza foglie protesi verso quel cielo azzurro spento che è tipico delle giornate di faugnu. Questo ininterrotto camposanto vegetale colpisce molto l’occhio del viaggiatore, meno quello di chi qui ci abita e da un po’ di tempo ha ormai completato il ciclo del lutto. Ci si abitua a tutto, come ha dimostrato la pandemia di Covid, e questa non è certo l’unica analogia fra virus degli umani e il suo antesignano vegetale: anche Xylella ha avuto gli scienziati capri espiatori, gli esperti da tastiera, i complottisti e i negazionisti che rifiutando l’esistenza della malattia e opponendosi alle misure di controllo hanno di fatto agevolato la distruzione agricola e paesaggistica di un intero territorio e consegnato all’Italia una bomba fitosanitaria che è ben lungi dall’essere disinnescata. Va considerato infatti che Xylella non colpisce solo l’ulivo ma anche parecchie altre specie vegetali.
In Puglia il batterio copre ormai il 40% del territorio e punta verso nord al ritmo di qualche decina di chilometri ogni anno. Per Xylella non esistono cure, nel caso degli ulivi ci sono solo due varietà che per il momento sembrano essere resistenti, per il momento perché i dati sono necessariamente limitati al tempo trascorso dagli inizi degli esperimenti e quindi sul futuro non c’è certezza.
Il problema oggi è ripiantare le varietà resistenti e sperare che durino: degli 85 mila ettari di ulivi la maggior parte è morta ormai da anni, i campi però sono ancora in attesa di essere estirpati e poi rimpiantati. Sulle prime estirpare un ulivo era una faccenda complicata fino al confine con l’impossibile dal fatto che si tratta di una specie protetta, nei territori colpiti da Xylella questo problema è stato superato ma continuano a mancare i fondi. Il costo complessivo del rimpianto dei dieci milioni di ulivi morti solo nella provincia di Lecce si aggirerà attorno ai 700 milioni di euro, dei quali ad oggi ne sono stati stanziati complessivamente poco più di 200, nel frattempo le aziende che hanno investito nei mezzi necessari a estirpare gli alberi e farne combustibile per le centrali a biomassa sono costrette a tenerli fermi nei piazzali. Secondo Melcarne basterebbe creare una fotografia della situazione attuale, un documento che certifichi agli olivicultori il numero esatto delle loro piante, in modo che se decidono di non perdere altro tempo e di reimpiantare a loro spese possano poi partecipare ai bandi successivi e ottenere a posteriori il rimborso.
Oltre alla lentezza della burocrazia, l’altro grande problema qui è da sempre quello di legare i contributi all’effettivo svolgimento delle attività agricole, fare insomma in modo che i soldi pubblici contribuiscano alla salute di aziende attive e alla tutela del territorio e non alla mera rendita fondiaria. “L’erogazione della cosiddetta integrazione comunitaria è già legata allo svolgimento di alcune buone pratiche agricole, a partire dallo sfalcio delle erbe, molti proprietari però percepiscono i soldi e poi non fanno i lavori, il risultato è un aumento esponenziale del rischio di incendio”. Gli incendi di oliveti secchi si sono moltiplicati nell’estate del faugnu e dopo le fiamme sotto la terra arsa rimangono le radici, a quel punto difficilissime da eliminare. Se poi i campi bruciati avevano gli impianti a goccia nel terreno finisce anche la plastica dei tubi sciolta dal fuoco.
Dietro l’incubo fitosanitario continuano insomma a coesistere i vecchi vizi e le farraginosità burocratiche di sempre, nel frattempo le macchine per le moliture dei frantoi vengono vendute in Grecia, Spagna e in Algeria, perché ormai è evidente che la maggior parte di loro non riprenderà più l'attività. “L’unico aspetto positivo è che se riusciamo a reimpiantare 40mila ettari con le tecniche di oggi possiamo fare la stessa produzione che prima facevano con 85mila. Si evita così la monocoltura ma rimane il problema di cosa fare con i 45mila ettari mancanti, cosa piantare, dove rimboschire e come, insomma serve una visione complessiva del futuro di questa terra e questa a oggi manca.” conclude Melcarne. Dopo 7 anni dall’inizio della crisi si attenderà che la politica si muova ancora una volta un passo abbondante dietro a tutti gli altri.
Oltre alle distese di ulivi morti e ai campi bruciati nel Salento del 2021 si vedono ovunque i manifesti delle discoteche storiche del territorio accompagnati però dalla specificazione in calce “NON DISCOTECA”, un escamotage da tempi di Covid. Nell’estate di LSG il movimento reggae e dancehall era invece al suo apice, fra Otranto e San Foca ogni sera si tenevano più eventi con migliaia di persone, talvolta decine di migliaia. Il Salento in quel periodo era noto anche come la Giamaica d’Italia, concetto ribadito non solo nelle canzoni dei Sud Sound System e dei Boomdabash ma anche da un coro della curva del Lecce “Salento e musica/dell’Europa la Giamaica/vento sole caldo d’Africa/la terra più bella che c’è”.
Negli anni novanta contribuì alla costruzione di questa analogia giamaicana anche l’invasione del Salento da parte di tonnellate di erba albanese a bassissimo prezzo, un fenomeno all’origine delle fortune dei Salvatore Petrachi e Adamo Greco, i due personaggi principali di LSG. Tuttavia il fatto che l’ambiente fosse ammorbidito dall’erba di Lazarat in arrivo via gommone non può far passare in secondo piano il fatto, più unico che raro, che per un periodo lungo circa vent’anni nel Salento due generi musicali del tutto estranei al territorio (il reggae e la dancehall) si siano fusi con il dialetto salentino, con gli echi di tradizioni contadine (un esempio fra i più riusciti è il testo di “Solidu comu na petra” dei Sud Sound System) e influssi di altri generi musicali per creare un movimento giovanile spontaneo che montava torri di casse sulle spiagge, sulle scogliere, negli uliveti per ballare fino all’alba.
Inevitabilmente, durante le notti di quell’epoca, il selecta girava il disco giamaicano sul lato della strumentale e molti ragazzi si mettevano a cantare in raggamuffin dialettale le loro storie di vita quotidiana. Non erano solo universitari o frequentatori di centri sociali come erano stati i fondatori del movimento, ma da un certo momento in poi anche vagnoni di paese dai lavori umili quando non umilissimi.
Fra di loro anche Rocco, fra i personaggi di LSG forse il mio preferito, un muratore-spacciatore poco più che ventenne diviso fra lavoro in cantiere di giorno (ogni estate il Salento si riempie di cantieri pubblici e privati non pianificati per tempo) e dancehall di notte, ritmi impossibili sostenuti solo grazie alla giovane età e alla cocaina. Alcuni metri sotto quello che era una sorta di Apollo Theatre del reggae italiano, il Mamanera di San Foca, oggi scorre invisibile il microtunnel della TAP.
Sopra, sulla spiaggia, le dancehall del locale sono ferme da due estati per via del Covid e gli unici segni rimasti di quella festa lunga vent’anni sono l’insegna all’ingresso e i bidoni della raccolta differenziata con i colori dell’Etiopia. A vedere il posto oggi, con lettini, ombrelloni e famiglie che prendono il sole, chi non c’era non potrebbe mai immaginare cosa è stata quella spiaggia per decine di migliaia di persone, non solo salentine. Nel tempo quella che sembrava solo una questione di divertimento notturno si è fatta immaginario, ha creato formule buone per l’inconscio che resistono anche oggi che quel tipo di festa pare tramontato.
La retorica del pan-salentinismo diffusa dei primi dischi dei Sud Sound System – una sorta di nazionalismo salentino che propugnava orgoglio e un forte riscatto etnico e linguistico, in primis attraverso l’uso programmatico del dialetto – si è sedimentata dentro il modo di vedere sé stessi e gli altri, ovvero i non salentini. Quando Checco Zalone imitando Giuliano Sangiorgi dei Negroamaro gli fa dire dire “Siamo andati negli Stati Uniti, un posto a occidente del più famoso Salento” coglie con la consueta precisione l’aspetto comico, talvolta grottesco, di questa esplosione identitaria che come molte altre cose in Salento tende a mancare di misura, il che è il suo fascino e il suo limite, come evidenziato anche dagli articoli satirici di “Salento XIX”, una sorta di lercio.it salentino che ha purtoppo cessato le pubblicazioni ma ha ancora online il suo archivio.
Sempre in quest’ottica alcuni miei amici hanno una teoria scherzosa che, forse in virtù del mio essere salentino a metà, condivido, ovvero che sia sufficiente risalire al massimo 2 gradi di separazione e non ai consueti 6 della teoria di Frigyes Karinthy per giungere all’origine salentina di un qualsiasi grande evento dell’umanità. Non basta però certo il reggae per spiegare come sia possibile che molti qui scambino l’interesse dei turisti per le spiagge con le acque trasparenti per una tacita attestazione di superiorità della civiltà salentina, per provarci bisogna quindi prendere in considerazione la natura di penisola – tendente all’isola culturale – di un territorio che non solo giunge all’estrema propaggine sud-orientale d’Italia ma nella sua storia ha conosciuto scorribande saracene, una nobiltà parassitaria e in tempi più recenti fenomeni di emigrazione di massa verso il nord d’Italia e d’Europa.
Un popolo fiero di sé ma che nella sua componente un tempo contadina conserva ancora nelle espressioni dialettali, negli assunti pregiudiziali, negli atteggiamenti che passano di generazione in generazione, un’abitudine naturale a considerarsi la parte perdente e predata dei rapporti di forza. Un popolo avvezzo all’economia a somma zero tipica delle società contadine, una visione per cui la ricchezza complessiva non aumenta mai, al massimo si sposta da una persona all’altra e di solito non per motivi nobili. Con la limitata e parziale eccezione del capoluogo i salentini sono stati a lungo abituati ad essere ai margini, ignorati dal resto del Paese. Il Sud del Sud.
Un tempo, lo ricordava anche Guido Piovene nel suo insuperato Viaggio in Italia, era impossibile trovare un albergo ad di fuori di Lecce, allora il Salento era una terra prettamente agricola, povera ma come si suol dire dignitosa, a lungo priva di quei fenomeni criminali che hanno invece contraddistinto altre aree del meridione. Un feudo ai margini del territorio conosciuto, con i suoi tramonti da landa alla fine del mondo, la terra rossa, i cieli screziati, i silenzi spezzati solo dal volo degli uccelli, gli ulivi e in quel tempo davvero nessuna vocazione turistica, un fatto che a posteriori sembra del tutto inspiegabile ma ha fornito quel fascino dell’inesplorato che ha contributo a mettere in moto ciò che è accaduto dopo.
É stata proprio l’invasione dei forestieri a ridefinire i termini di quella divisione, che nel Salento è ancora nettissima, fra città e paesi. Lecce è stata una città di nobili e latifondisti prima, avvocati, burocrati e professionisti dopo, genti sospese fra una pulsione teorica all’internazionalità e un’innata e inconfondibile leccesità, dall’altra parte invece ci sono i paesi contadini, più sanguigni, dialettali, folkloristici e per molti versi anche più naïf: teste così esposte alla furia energica della tramontana da finire spesso per riprodurla nei comportamenti, negli atteggiamenti e in un certo modo binario di vedere il mondo.
Un esempio straordinario di questa identità salentina di paese è l’architettura sincretica di molte case private costruite nella seconda metà del novecento, abitazioni spesso edificate grazie alle rimesse degli immigrati, progettate sommando a piacere gli esempi contenuti nei manuali di architettura e declinandoli secondo le possibilità produttive del posto. Il risultato è una sorta di barocco moderno e informale che è stato considerato a lungo un semplice obbrobrio, un’offesa alla vista, e solo di recente è stato teorizzato come una corrente architettonica da un libro originale e ben riuscito: “Salento Moderno – Inventario di abitazioni private del Sud della Puglia ” (Humboldt 2018), curato da Davide Giannella e Massimo Torrigiani.
Proprio Torrigiani descrive queste case come costruzioni “dalle strutture semplici, progettate dai geometri e poi arricchite con furore decorativo”. Torrigiani dice di aver sempre considerato quelle case così anomale e poco stimate come una sorta di Salento “alternativo a quello delle masserie”, più vivo, meno chic, un Salento costruito da persone “che volevano distinguersi”. Impossibile non riconoscere, in queste costruzioni che sfoggiano alla rinfusa tante ispirazioni diverse, quella grandeur vitale e ingenua che è la specifica tonalità di naïf che contraddistingue la cultura salentina di paese, la stessa dei due gradi di separazione e del pan-salentinismo, una mentalità caratterizzata della volontà di esprimersi senza prestare attenzione al canone – o forse senza neppure conoscerlo – e senza alcun interesse o timore reverenziale nei confronti delle cerimoniose formalità borghesi che sono tutt’al più una faccenda da leccesi.
Il passaggio da periferia dell’esistente (citando un noto pugliese del nord) a gettonato hashtag di Instagram grazie al boom del turismo è avvenuto in maniera così repentina che è come se all’improvviso si fosse aperto nel terreno un enorme giacimento di petrolio.
I risultati in alcuni casi sono stati paradossali come è accaduto ad esempio nel comune di Melendugno, un territorio dotato di alcune delle marine più belle delle costa adriatica, fra le quali spicca la lunga spiaggia sabbiosa (merce piuttosto rara da queste parti) di Torre Dell’Orso, con i suoi fotografabilissimi faraglioni delle Due Sorelle; un territorio paesaggisticamente inestimabile sfregiato da ormai due decenni abbondanti di speculazione edilizia e turismo di massa: parcheggi, villaggi e case private che negli anni si sono spinte a fondo nell’entroterra. Così come Porto Cesareo o Gallipoli, nei discorsi dei salentini “Torre dell’Orso” è diventato negli ultimi anni sinonimo di sovraffollamento, un luogo simbolo di cosa succede quando la gestione del turismo fallisce nel tentativo di sviluppare il comparto economico tutelando al contempo il territorio.
Non senza una certa ironia è stato proprio il comune di Melendugno a erigersi difensore del territorio salentino durante la battaglia contro la TAP, il che mostra tutti gli enormi limiti della retorica identitaria quando diventa solamente uno slogan senza sostanza. La scena madre di tutte le proteste contro la TAP è stata quella in cui i sindaci provenienti da tutto il Salento protestavano con tanto di fascia tricolore a tracolla per la rimozione temporanea di 1100 ulivi dal tracciato del gasdotto, il tutto mentre nella stessa provincia veniva lasciata libera la Xylella di ucciderne definitivamente dieci milioni. È sul sottile ma sostanziale confine fra massimi sistemi e retorica da una parte e capacità pratica di governo dall’altra che si snodano molti dei problemi che hanno segnato in maniera pesante la storia salentina degli ultimi anni, cambiando il territorio in maniera radicale.
Da TAP nel frattempo fanno notare come in nessun altro territorio interessato da opere di questo tipo sia accaduto quello che è successo nel Salento e si rammaricano che nessun rappresentante del comune di Melendugno ad oggi abbia fatto visita all’impianto, ormai completato e funzionante e, aggiungo io che invece l’ho visitato, modernissimo e iper-tecnologico. Allo stato attuale delle cose il comune di Melendugno si ritrova con l’opera finita sul suo territorio e nessun soldo ricevuto per il disturbo, un lose-lose da manuale, una gestione simbolo di una classe politica che piuttosto che tutelare il territorio per i rischi che si assume impegnandosi in trattative anche dure con gli interlocutori di turno preferisce cavalcare il malcontento massimalista e finisce così per ritrovarsi senza niente in mano. É in casi come questi che la grandeur salentina smette in fretta di essere bonaria e divertente e incomincia a generare domande. La società del gasdotto ha speso 15milioni di euro solo per spostare con navi e sommozzatori le biocostruzioni e i coralli sul tracciato del tubo e poi rimetterli al loro posto una volta completato l’impianto e ora che l’opera è conclusa e ci si è resi conto che la sua presenza è molto più discreta di quanto non prospettassero molti No-TAP anche a Melendugno le persone incominciano a farsi delle domande su come sia stata gestita la vicenda.
(Continua a leggere su Il Foglio)
Sempre su Domani:
PEPPA PIG. Un racconto di sesso, capitalismo e automazione
Scrivere è riscrivere. Una riflessione sulla nuova edizione di LASCIA STARE LA GALLINA
A proposito della gallina, grazie dell’entusiasmo con cui avete accolto la ristampa negli Oscar Mondadori. Lu Petrachi vi saluta e dice che se vi serve casa nel Salento lui ha diversi annunci su Airbnb ma se poi vi piacciono le foto chiamatelo, non passate dalla piattaforma, così risparmiate entrambi.
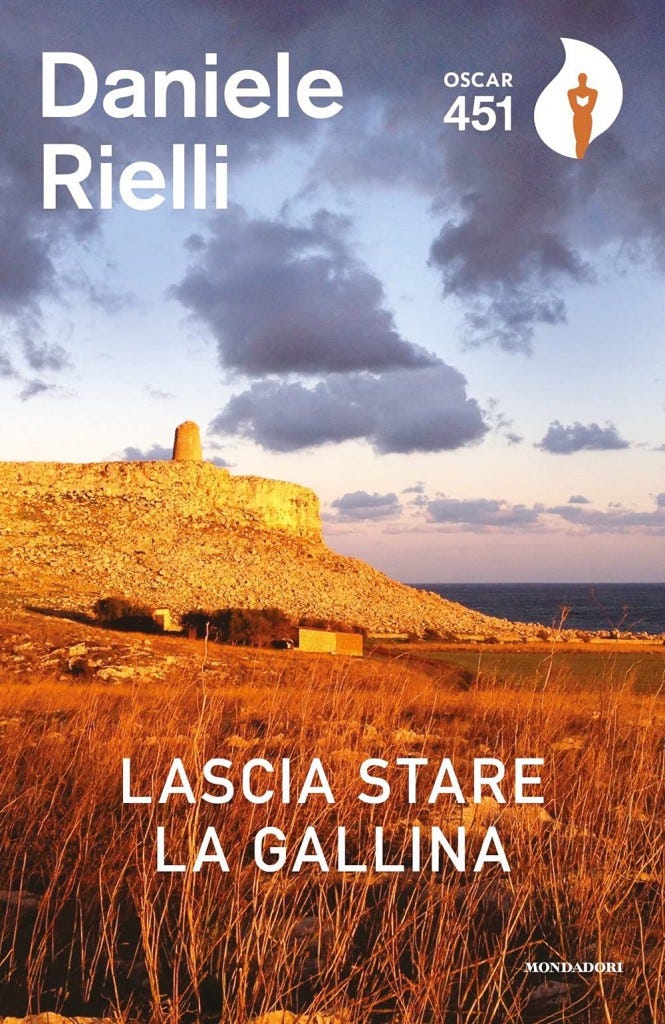
Beh, è tutto, Ciao!*
* questa è una nuova idea per una start up per cui sto cercando finanziatori: al posto delle emoticon o dei meme usiamo una sequenza di lettere codificata appositamente per indicare degli oggetti, stati d’animo o azioni (o anche qualsiasi altro emoticon, è un progetto è molto scalabile). Ad esempio:
Si potrebbe sostituire con:
CIAO



